Da qualche anno, quando novembre si avvicina, la mia agenda viene occupata dalla memoria della Grande Guerra. È inevitabile, oltre che giusto: se il calendario civile chiama, la Public History risponde “presente”. Uno storico che vuole avere un ruolo sociale non può ignorare le date che le comunità e le istituzioni segnano in rosso. Neppure quando sono scomode.

La rotta di Caporetto è una delle spine più appuntite della memoria della Grande Guerra.
Avvicinarmi alla memoria della Grande Guerra e alla storia locale del 1914-1918 non è stato affatto semplice. Vedevo entrambi i campi occupati da una retorica paternalista, nazionalista e militarista. Nei profili dei monumenti ai caduti scorgevo le ombre lunghe del fascismo. Tra la Leggenda del Piave e il grido di “onore ai caduti” mi sembrava che le società sguainassero ancora l’educazione al conflitto. Non lo sopportavo proprio, quello spirito marziale. Eppure, non riuscivo a stare lontano dalla Prima guerra mondiale. Per capire il Novecento, “il Secolo breve”, finivo continuamente immerso nei racconti delle trincee e nelle angosce dei fronti interni. Fino a quando, in una sera d’inverno, un grumo di frasi ha ricomposto il senso che giaceva smarrito sotto al mio naso.
La guerra era l’invisibile ovunque, il suo battito gonfiava le vene degli uomini, suonava con le campane dei villaggi, tuonava la notte durante la tempesta. La guerra erano i giorni del calendario. Era la cifra del secolo. Era il lamento dei poveri, la rabbia dei deboli. Era la fame. Era la morte.
(Yvan Goll, Requiem per i morti d’Europa, Ginevra, 1917)
Da quando ho letto queste parole, non ho più smesso di vagare tra libri e faldoni d’archivio alla ricerca di quel maledetto “invisibile ovunque”. Ho capito che la sua essenza mi circondava senza esserci, proprio come la memoria della Grande Guerra. In ogni angolo d’Italia c’è almeno una lapide, una statua, una tomba che racconta in silenzio uno spicchio del 1914-1918. Uno scampolo di un secolo fa, un fossile del Novecento, una voce muta. Perché cercare di ascoltarla in un mondo che marcia nella frenesia? Che cosa può dire a noi, oggi, la sua esperienza? Per le domande disarmanti bisogna trovare risposte che illuminino la notte. Ed ecco, sempre, Yvan Goll: quel silenzio così eloquente è vivo perché racchiude “la rabbia dei deboli”.

Cartolina propagandistica che incita gli italiani a resistere sulla linea del Piave.
Quanta rabbia, e quanta paura, tra il 1918 e il 1922! Prima si grida al “tradimento” per la rotta di Caporetto, poi si diffida dei “disfattisti” e dei “sovversivi”. I contadini però in trincea ci tornano solo in cambio di una bella promessa: parole di riforma agraria s’innalzano dalla resistenza sul Piave e si sciolgono come neve al sole dopo Vittorio Veneto. “Dov’è la Vittoria”, se bisogna tirare sempre di più la cinghia? I nazionalisti s’imbizzarriscono perché la credono “mutilata” dalle trattative di pace. Poi D’Annunzio la ghermisce a Fiume, gettando benzina sulle fiamme del confine orientale. Altro che pace: italiani sparano addosso ad altri italiani. Camicie nere manganellano chi sogna una rivoluzione già mancata in partenza. Tanti commercianti e piccoli proprietari, sentendosi “penultimi”, gridano contro il “complotto” dei “primi” e la minaccia degli “ultimi”. Quanto vorrebbero un po’ di sicurezza, un governo autoritario, un capo che “faccia un po’ di pulizia”, un “posto al sole”.
La memoria della Grande Guerra… oggi
Rabbia e paura, gli stessi sentimenti di oggi. I sogni d’ordine del piccolo ceto medio s’incarnano in Mussolini, che declina in senso fascista la memoria della Grande Guerra per legare la camicia nera alla “Patria”. La retorica insegna che grandezza della nazione passa attraverso la violenza della conquista. S’innesca un meccanismo che conduce l’Italia verso un perenne stato di conflitto. Verso l’aggressione dell’Etiopia, il sostegno al franchismo, i crimini commessi nei Balcani, la mobilitazione totale, l’8 settembre 1943.

La statua del fante, opera di Mario Sarto, parte del Monumento ai Caduti di Crespellano.
Queste storie le abbiamo dimenticate, ma alcuni luoghi della memoria sembrano fatti apposta per ricordarcele. L’esempio perfetto è il Monumento ai caduti di Crespellano. Dagli anni Trenta il fante di Mario Sarto alza al cielo di un Comune che fu socialista la bandiera del nazionalismo. Il regime fascista segna il territorio per cambiare la storia e cancellare chi si oppone. Esalta la guerra, ma è proprio un conflitto a farlo crollare. Ai contadini-soldati, morti fra le trincee e gli ospedali del primo conflitto mondiale, si aggiunge l’elenco di un’altra generazione. Quella della Resistenza. Nomi e cognomi incisi sul basamento della statua, perché nessuno impugni più la memoria della Grande Guerra come un’arma. Perché si leggano i risultati della violenza.

Il basamento del Monumento ai Caduti di Crespellano. Nella parte bassa si leggono i nomi dei partigiani morti durante la lotta di Liberazione.
Parole di pietra
Ecco perché, ogni anno, mi piace riflettere sull’eredità che il primo conflitto mondiale ha lasciato all’Europa, all’Italia e all’Emilia. Qualche mese fa ho condensato nel saggio Radici di futuro ricerche e riflessioni sulla memoria nella valle del Samoggia. E ora avrò il piacere di raccontare il mio lavoro in una conferenza insieme allo storico Giacomo Bollini, autore di diverse pubblicazioni sulla Grande Guerra, e a Federica Trenti. Anche in quest’occasione ANPI Crespellano e l’Associazione Emilia-Romagna al Fronte s’impegnano a costruire un confronto sulla storia e sulla memoria della comunità. Un dialogo che si proietta fino al confine orientale, dove tutto ha avuto inizio. E dove Giacomo ha scoperto storie di una guerra (dis)umana, condensate in altrettanti luoghi della memoria. L’appuntamento è fissato per sabato 28 ottobre alle 17:30 a Valsamoggia, località Crespellano, nella sala conferenze di Palazzo Garagnani.

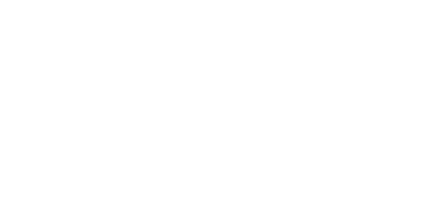








Lascia un commento